Rassegna di giurisprudenza: tre sentenze di estremo interesse nel primo semestre 2017
a cura di Bernardina Calafiori*
1 – Cass. Civ., Sez. lav., 16 gennaio 2017, n. 862: Rapporto di lavoro – Socio lavoratore – Trattamento di Fine Rapporto – Fatti concludenti – Ammissibilità.
“Deve ritenersi ammissibile la domanda del socio lavoratore volta ad ottenere la corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) laddove esso, sebbene non espressamente contemplato dallo statuto della cooperativa, abbia comunque costituito l’oggetto di appositi accordi in tal senso, ancorché comprovati da fatti concludenti, purché tali da aver ingenerato nel socio lavoratore un legittimo affidamento.”
Il caso deciso con il provvedimento in epigrafe riguardava l’accertamento della corresponsione, da parte di una cooperativa, di un importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) in favore di un socio lavoratore che aveva prestato la propria attività lavorativa per oltre dieci anni. Tale importo veniva rivendicato in giudizio ancorché nessuna clausola statutaria della cooperativa lo garantisse espressamente. Per questi motivi, il Tribunale rigettava il ricorso del socio lavoratore. La statuizione veniva poi confermata dalla Corte di Appello. In particolare, i Giudici di secondo grado rilevavano, da un lato, come nessuna previsione contenuta nella legge n. 142 del 2001 – che disciplina sistematicamente il rapporto di lavoro del socio di cooperativa
– prevedesse il TFR quale vero e proprio diritto del socio; d’altro lato, come non fosse sufficiente l’aver il socio prodotto in giudizio i prospetti paga relativi agli anni 2000-2003 ed il modello CUD 2003 al fine di comprovare, sia pure in via presuntiva, l’esistenza di un diritto al TFR basato su formali accantonamenti della retribuzione mensile.
La Corte di Cassazione riformava integralmente la pronuncia di appello, ricordando che il diritto del socio lavoratore alla corresponsione del TFR può essere oggetto non solo di apposita previsione statutaria o assembleare, ma anche di comportamenti concludenti tali da sottendere un vero e proprio accordo. Sicché, prosegue la Corte di Cassazione, l’errore in cui era incorsa la Corte di Appello consisteva proprio nell’aver disconosciuto l’esistenza di elementi idonei a comprovare una volontà della cooperativa di riconoscere, anche solo per facta concludentia, un diritto al TFR a beneficio dei propri soci lavoratori.
Il provvedimento in commento recupera e fa propri i principi generali enunciati da un consolidato filone giurisprudenziale (tra cui si ricordano: Cass. Civ., Sez. lav., 24 luglio 2004, n. 13956; Cass. Civ., Sez. lav., 3 agosto 2004, n. 14878; Cass. Civ., Sez. lav., 11 giugno 2010, n. 14076; Cass. Civ., Sez. lav., 10 maggio 2016, n. 9479) avente ad oggetto l’accertamento della possibilità, oppure no, per il socio lavoratore di poter legittimamente aspirare al Fondo di garanzia per il TFR istituto ex art. 24 della legge n. 196 del 1997, allorché siano ravvisati determinati requisiti minimi di operatività (tra cui, il versamento della contribuzione prescritta dall’art. 24, comma 1, ult. cit.).
2 – Trib. Roma, 13 aprile 2017, n. 3636: Risoluzione rapporto di lavoro – Transazione – Incentivo all’esodo – Corresponsione al netto – Inammissibilità.
“Deve ritenersi illegittimo, perché viziato da nullità, qualsiasi patto tra datore di lavoro e lavoratore volto a far ricadere sul primo gli oneri tributari, incombenti per legge sul secondo, risultanti a seguito di ricalcolo dell’aliquota fiscale relativa ad importi qualificati come “netti” in un accordo conciliativo.”
Il caso deciso con il provvedimento in epigrafe riguardava il corretto inquadramento dell’impegno di un datore di lavoro a corrispondere in misura “netta” importi qualificati a vario titolo (incentivo all’esodo, TFR, transazione generale novativa etc.) all’interno di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La vicenda trae origine da un avviso notificato (ricevuto nel 2015) dall’Agenzia delle Entrate al dipendente, con cui l’Amministrazione informava che gli importi “netti” corrisposti in forza dell’accordo conciliativo (sottoscritto nel 2011) avrebbero dovuto essere assoggettati a diversa aliquota fiscale. Ragion per cui l’Agenzia procedeva al ricalcolo dell’aliquota applicabile e, per l’effetto, alla riliquidazione degli importi ancora dovuti dal dipendente.
Il dipendente conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro, chiedendo che fosse condannato al pagamento di una somma esattamente corrispondente a quanto preteso dall’Agenzia delle Entrate a seguito del ricalcolo fiscale. A sostegno delle sue conclusioni, il lavoratore assumeva il presunto inadempimento dell’accordo conciliativo da parte del datore di lavoro nella parte in cui non avrebbe corrisposto i dovuti importi “al netto” di qualsiasi aliquota fiscale. Il Tribunale riteneva di non poter accogliere il ricorso del lavoratore.
In particolare, il Giudice del lavoro rilevava, da un lato, come il datore di lavoro avesse correttamente “lordizzato” gli importi riconosciuti come “netti” con l’accordo conciliativo, in applicazione dell’unico sistema di trattenuta fiscale vigente al tempo della conciliazione. D’altro lato, come l’Agenzia delle Entrate debba in ogni caso provvedere alla riliquidazione dell’imposta sul reddito del lavoratore, inizialmente applicabile soltanto a titolo di “acconto”, tenendo conto dell’aliquota media di tassazione relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui gli importi tassati sono stati percepiti. Sicché, a prescindere da quello che è stato l’operato del datore di lavoro in sede di prima imposizione, l’aliquota fiscale applicabile viene sempre rideterminata, successivamente, in via definitiva e senza alcun riferimento alla fase dell’“acconto”. Del resto, evidenzia il Tribunale, il datore di lavoro effettua le trattenute fiscali agendo esclusivamente come mero “sostituto di imposta” e, cioè, anticipando all’erario un debito che è – e resta – ad esclusivo carico del lavoratore. E sono proprio queste le determinanti ragioni per cui, conclude il Giudice del lavoro, ogni patto volto all’accollo definitivo ed esclusivo dell’onere tributario da parte del datore di lavoro, per come risultante all’esito di eventuali ricalcoli dell’aliquota fiscale, sarebbe stato nullo.
Il provvedimento in epigrafe costituisce una significativa conferma di un orientamento giurisprudenziale già precedentemente consacrato dallo stesso Tribunale di Roma (cfr. Trib. Roma, sentenza del 28 gennaio 2011, n. 1482), nonché adottato da altri Giudici Italiani (cfr. Trib. Milano, sentenza del 31 ottobre 2012).
3 – Cass. Civ. Sez. lav., 9 giugno 2017, n. 14457: Estinzione rapporto di lavoro dirigenziale – Patto di stabilità – Retribuzione – Corrispettività – Ammissibilità.
“Deve ritenersi ammissibile interpretare un aumento retributivo concesso ad personam ad un dirigente, contenuto nel contratto di assunzione, quale corrispettivo del sacrificio connesso alla stipula di un c.d. “patto di stabilità”, contenuto nel medesimo contratto di assunzione, a nulla rilevando che quell’aumento non sia stato espressamente contemplato nel patto.”
Il caso deciso con il provvedimento in epigrafe riguardava la legittimità di un patto di stabilità (anche noto come “clausola di durata minima”) incluso nel contratto di lavoro sottoscritto da un dirigente con il proprio datore di lavoro e, in particolare, le modalità di determinazione del corrispettivo eventualmente dovuto a fronte di simili patti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello territoriali avevano ritenuto nulla la clausola di durata minima in quanto il contratto di lavoro non prevedeva alcun corrispettivo “specifico” ulteriore rispetto alla retribuzione accordata nel medesimo contratto. La Corte di Cassazione ha ribaltato il giudizio della Corte territoriale con un ragionamento che scandisce sapientemente i passaggi logico/giuridici attraverso cui valutare la legittimità della clausola in esame. Punto di partenza di questa analisi è che l’ordinamento giuridico italiano non pone alcun limite all’autonomia privata del lavoratore nell’esercizio della sua facoltà di recesso dal rapporto di lavoro. Ne deriva, pertanto, che ben può il lavoratore, anche dirigente, sottoscrivere una clausola di durata minima apposta al suo contratto di lavoro. Poste queste premesse di ordine generale, la Corte di Cassazione si interroga sulla necessità di prevedere un corrispettivo a fronte della stipula della clausola di durata minima dando, incidentalmente, una risposta affermativa. Quindi i Giudici di legittimità si interrogano sulle modalità di determinazione di tale corrispettivo e, precisamente, se la retribuzione pattuita nel contratto di lavoro può assurgere a tale funzione. Anche in questo caso la risposta è affermativa. Ed invero, posto che laddove la legge ha previsto un compenso “specifico” lo ha fatto esplicitamente (cfr., a tal riguardo, art. 2125 Cod. Civ. in tema di patto di non concorrenza) e posto che la clausola di durata minima non rientra tra queste ipotesi, il corrispettivo dell’impegno del lavoratore a non recedere può legittimamente essere valutato avendo come riferimento non già la singola clausola di durata minima, bensì l’intero assetto contrattuale all’interno del quale essa è collocata. Ed infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, nei rapporti a prestazioni corrispettive, come i rapporti di lavoro, le contrapposte prestazioni non devono essere valutate “atomisticamente”, ma alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni in cui si innestano, tra cui figura anche la retribuzione. Ciò, precisa sempre la Suprema Corte, sempreché la retribuzione ecceda il minimum sancito dall’art. 36 Cost. e compensi la “temporanea rinunzia del lavoratore alla sua facoltà di recesso”. Compensazione che è certamente ravvisabile, precisa la Suprema Corte, nel caso in esame, per aver goduto il dirigente di una maggiorazione della retribuzione di molto superiore rispetto al minimo contrattuale, a fronte di una clausola minima di durata di soli 12 mesi. Da ultimo, la Suprema Corte non ha mancato di puntualizzare come il corrispettivo ben possa consistere anche in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, avente natura non-monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio.
* Avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Daverio & Florio

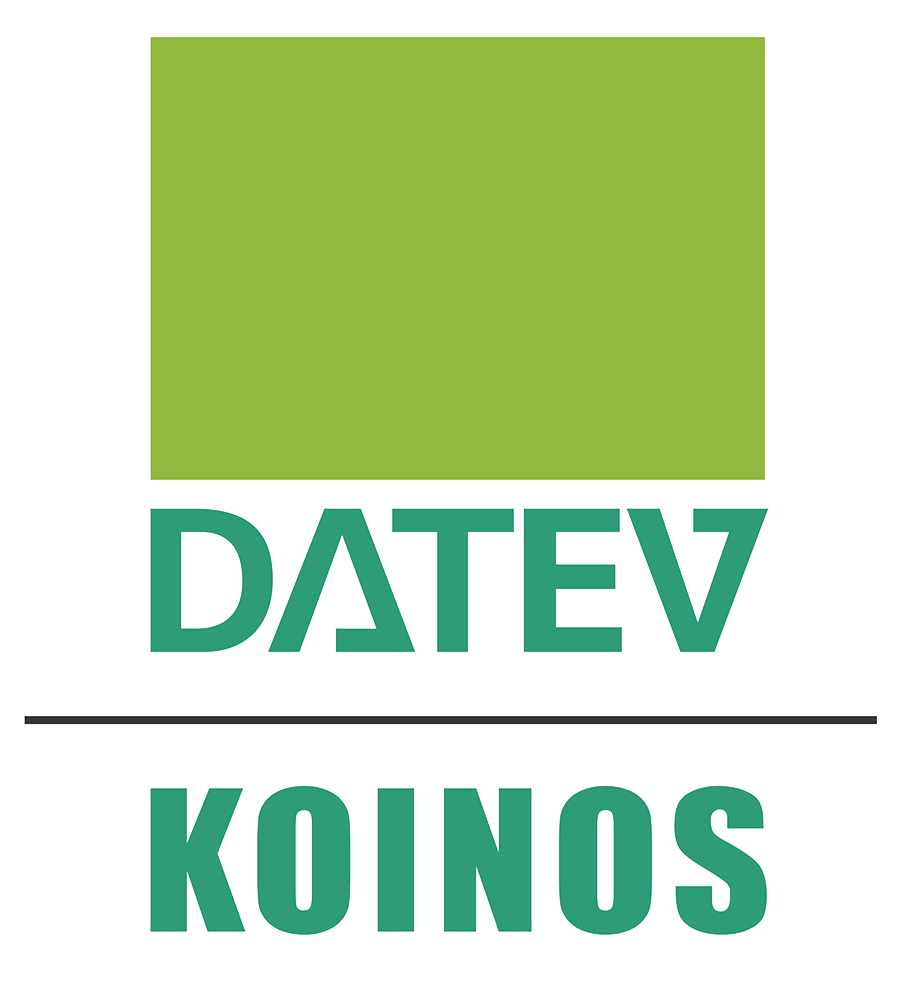






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!