Insussistenza del fatto, disposizioni collettive e licenziamenti disciplinari: un intreccio che il Jobs Act prova a risolvere
di Evangelista Basile* e Fabio Fontana **
Nell’ambito dei licenziamenti intimati per ragioni disciplinari, il fatto contestato – da intendersi come una condotta e/o
un’omissione di cui il lavoratore si è reso responsabile – ha sempre rivestito un ruolo centrale. Basti pensare che l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori impone al datore di lavoro, in sede di procedimento disciplinare, di identificare previamente con precisione tutte le caratteristiche del comportamento da contestare al dipendente.Con l’entrata in vigore della legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), il fatto ha poi assunto un ulteriore valore, nella misura in cui il legislatore, al novellato art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), ha previsto la reintegra nel posto di lavoro “per insussistenza del fatto contestato” (oltre che nel caso, come si dirà, in cui il
fatto – pur sussistente – avrebbe dovuto essere punito con una sanzione conservativa per volontà del contratto collettivo o del regolamento interno). L’obiettivo dichiarato dal Parlamento italiano andava identificato nella volontà di ridurre sensibilmente la discrezionalità dei giudici, circoscrivendo le ipotesi in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto reintegrare in servizio il dipendente licenziato. Tuttavia, la formulazione della disposizione, che a una prima lettura
poteva sembrare chiara, in sede di concreta applicazione ha costretto i giudici di merito e di legittimità a interrogarsi sul significato del termine “fatto”, concentrandosi in particolare sui problemi della rilevanza disciplinare dell’addebito contestato al lavoratore e dell’elemento soggettivo della condotta. In quest’ottica i magistrati di merito e di legittimità hanno elaborato il concetto di “fatto giuridico” e di “fatto materiale”, pervenendo alla conclusione che “la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’articolo 18, quarto comma, cit.” (vds. Corte di Cassazione, sent. n. 20540 del 13 ottobre 2015). Al contempo, sul tema dell’elemento soggettivo della condotta, i giudici del lavoro, partendo dalla considerazione che il “fatto” rappresenta un unicum globalmente accertato in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, hanno escluso la sussistenza del fatto nei casi in cui mancavano nella condotta gli elementi psicologici del dolo e/o della colpa grave, laddove necessari per giustificare il provvedimento espulsivo.
In altre parole, secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla magistratura del lavoro, non è sufficiente che sussista qualsivoglia “fatto” per escludere il rischio di una reintegrazione in servizio del lavoratore, dovendo il “fatto” medesimo assumere tutte le caratteristiche dell’inadempimento contestato, ossia integrarlo sotto il profilo oggettivo e soggettivo e rilevare sul piano disciplinare.
Altro problema che si è posto all’attenzione dei magistrati del lavoro in seguito all’entrata in vigore della Riforma Fornero attiene sempre all’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui il legislatore ha voluto riconoscere al dipendente licenziato il diritto di accedere alla tutela reintegratoria anche nel caso in cui “il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”. Giova a questo punto chiarire che le disposizioni collettive relative alle esemplificazioni di condotte disciplinarmente rilevanti sono sempre state utilizzate dalla giurisprudenza quali meri criteri per orientare la decisione in ordine alla legittimità del licenziamento.
I giudici del lavoro, pur ravvisandone la genericità e precisandone il carattere non vincolante, hanno sovente motivato le proprie decisioni con un attento richiamo alle pattuizioni intervenute a livello collettivo. La giurisprudenza di legittimità, in molteplici occasioni, ha infatti statuito che “in tema di licenziamento, le tipizzazioni degli illeciti disciplinari contenute nei contratti collettivi, rappresentando le valutazioni che le parti sociali hanno fatto in
ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità, non consentono al datore di lavoro di irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione” (ex multis, Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 2692/2015, n. 19053/2005, n. 16260/2004).
Con l’entrata in vigore della Riforma Fornero, però, le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)
hanno assunto per mano del legislatore un carattere estremamente vincolante laddove stabiliscono che una determinata condotta sia passibile solo di una sanzione conservativa. E invero, come si è visto, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, dello Statuto dei lavoratori, se il CCNL (o il regolamento interno) dispone che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, il giudice non può fare altro che dichiarare illegittimo il licenziamento e ordinare – quale sanzione imposta dalla legge – la reintegrazione in servizio del lavoratore. I magistrati del lavoro
si sono così trovati nell’impossibilità di poter valutare l’idoneità di un determinato fatto a legittimare un recesso in tronco ogniqualvolta che le parti collettive lo avevano inserito tra le infrazioni sanzionabili solo con un richiamo
scritto, una multa o una sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Una simile impostazione presenta inevitabilmente qualche problema nel momento in cui i CCNL elencano fattispecie tipizzate a dir poco insolite o eccessivamente lassiste. In questi termini, ad esempio, le aziende che applicano il CCNL Uneba (Unione Nazionale
Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale) si trovano a dover punire con una sanzione meramente conservativa colui che “assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale”. Le stesse difficoltà, invece, non si sono poste nelle ipotesi in cui il fatto contestato al lavoratore non era riconducibile a una delle fattispecie contemplate nei contratti collettivi. In questi casi i giudici del lavoro hanno potuto continuare a utilizzare le disposizioni dei CCNL come meri criteri orientativi, senza essere vincolati dalle pattuizioni intervenute tra le parti collettive. Sul punto, va annoverata la sentenza n. 6165 del 30 marzo 2016, con la quale la Suprema Corte si è espressa nell’ambito di una fattispecie in cui il dipendente, non avendo percepito una parte della retribuzione a lui dovuta, ha dapprima minacciato il titolare
dell’azienda di mettersi in malattia, poi si è effettivamente assentato dal lavoro per un evento morboso all’evidenza fittizio e, da ultimo – pur asseritamente malato – si è recato in azienda al solo fine di rivolgere al datore di lavoro la seguente frase: “qua dentro mi sto zitto ma fuori parliamo da pari a pari”. Il dipendente era anche recidivo, essendo già stato sanzionato con una sospensione di cinque giorni dal servizio e dalla retribuzione per aver manifestato il suo rifiuto a un cambio turno, a cui aveva fatto seguito un allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro e la pronuncia di espressioni minacciose. Per i giudici di legittimità il lavoratore ha diritto a essere reintegrato in servizio in quanto “la pronuncia di espressioni sconvenienti non seguita dal passaggio alle vie di fatto non realizza la fattispecie disciplinare, prevista dall’art. 35 lett. A bis) CCNL Porti, del diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuti all’interno dell’Azienda/Ente. Il datore di lavoro non può irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione”. A ben vedere, nel suddetto caso non si concretizza un’infrazione disciplinare per la quale il CCNL contempli una sanzione conservativa. Ciò nonostante la Suprema Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza in
tema di tipizzazione degli illeciti disciplinari, ha tratto spunto dalle altre fattispecie elencate nel Contratto Collettivo di settore, ritenendo che la condotta assunta dal dipendente fosse meno grave rispetto a quelle per cui le parti collettive avevano previsto la sanzione espulsiva. In particolare, secondo la Suprema Corte, la condotta contestata al lavoratore difettava dell’elemento del “passaggio alle vie di fatto”, sicché la stessa non poteva legittimare il recesso datoriale per giusta causa. In questi termini, la sentenza della Corte di Cassazione presenta significative analogie con la giurisprudenza in tema di insussistenza del fatto contestato, nella misura in cui la motivazione viene fondata
(seppur implicitamente) sull’insussistenza di un elemento costitutivo che caratterizza la condotta punita con la sanzione espulsiva. Una diversa impostazione è stata invece seguita dalla Corte di Cassazione nella recentissima
sentenza n. 10647 del 2 maggio 2017. I giudici di legittimità sono stati chiamati a esprimersi su un caso in cui il dipendente, assente dal lavoro per un infortunio alla caviglia, era stato sorpreso a partecipare a due partite di calcio,
che ne avevano pregiudicato la guarigione. Verificato che la fattispecie all’esame della Corte non era tra quelle elencate nel CCNL di riferimento, i giudici si sono correttamente concentrati sulla disposizione che dovrebbe
orientare ogni pronuncia relativa a un licenziamento per giusta causa: l’art. 2119 del codice civile. In particolare, la Suprema Corte, dopo aver confermato la legittimità del licenziamento, ha chiarito un principio di diritto assolutamente condivisibile, ossia che il giudice non deve limitarsi a ricondurre quanto addebitato alle singole fattispecie previste dalla contrattazione collettiva, ma deve valutare i fatti nel loro insieme onde verificare se siano tali da minare la fiducia del datore di lavoro. Proprio le criticità insorte nella interpretazione dell’art. 18 novellato dalla c.d. Riforma Fornero ha indotto il nostro Legislatore, ad appena tre anni di distanza, ad intervenire nuovamente sulla materia, dettando una disciplina diversa in materia di tutela da licenziamenti nulli o illegittimi nei contratti a tutele crescenti (ossia quelli decorrenti dal 7 marzo 2015). Innanzitutto nel decreto legislativo 23/2015, che regola i c.d. contratti a tutele crescenti, non vi è alcun riferimento nei licenziamenti disciplinari alle disposizioni contenute nei CCNL, che dunque perdono qualsivoglia efficacia vincolante e tornano a rivestire per i giudici del lavoro un ruolo
meramente orientativo. Del pari il legislatore ha tenuto a precisare che il lavoratore licenziato per ragioni disciplinari può accedere alla reintegrazione in servizio solo nell’ipotesi di “insussistenza del fatto materiale”, senza che possa incidere alcuna valutazione da parte del magistrato di proporzionalità tra addebito e sanzione. La nuova impostazione adottata dal legislatore condizionerà inevitabilmente le decisioni dei giudici sotto diversi profili. Alla luce dell’omesso richiamo alle disposizioni collettive, il giudice – sia nelle ipotesi in cui il fatto contestato rientri tra le infrazioni passibili di sanzione conservativa, sia nei casi in cui il fatto non sia contemplato tra le esemplificazioni del CCNL – non potrà disporre la reintegrazione in servizio nel momento in cui vi sarà la prova in sede giudiziale della sussistenza dell’addebito. Al più il magistrato, laddove ritenga il provvedimento espulsivo sproporzionato rispetto al fatto contestato, potrà condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura peraltro predeterminata
dalla legge stessa. Inoltre, alla luce della precisazione che per “fatto” deve intendersi la condotta o l’omissione nella sua materialità, il giudice, allorquando dovesse ravvisare che un determinato inadempimento non è idoneo
a legittimare un recesso in tronco, non potrà comunque riconoscere al lavoratore la tutela reintegratoria. Così se il datore di lavoro contesta al dipendente una specifica condotta (ad esempio, essersi rifiutato di recarsi presso
l’ufficio di un cliente), qualificandola come insubordinazione grave, e il giudice, dopo aver accertato l’esistenza del fatto contestato, dovesse considerarlo alla stregua di una insubordinazione lieve, una simile valutazione potrà comportare la condanna del datore di lavoro al solo indennizzo economico: il fatto contestato al lavoratore, nell’esempio ora prospettato, è stato accertato come sussistente nella sua materialità, essendosi il lavoratore effettivamente rifiutato di recarsi presso il cliente. Va tuttavia evidenziato che la disciplina delle tutele crescenti non ha risolto il problema della irrilevanza sul piano disciplinare del fatto contestato. Con tutta probabilità, i giudici del lavoro continueranno a esigere
che il fatto addebitato al dipendente abbia una qualche rilevanza sul piano disciplinare, dovendo consistere in una condotta o in un’omissione che concretizzi un inadempimento degli obblighi contrattuali o comunque una lesione del vincolo fiduciario. In questi termini, il datore di lavoro non potrà ritenersi al riparo dal rischio di una reintegrazione in servizio del dipendente, nell’ipotesi in cui dovesse contestare a quest’ultimo, per assurdo, di indossare un paio di occhiali con montatura di colore nero. Tale fatto, d’altronde, quand’anche accertato nella sua esistenza materiale, non può affatto assumere un qualche disvalore nell’ambito del rapporto di lavoro. In questi termini, le questioni più ardue da definire verteranno su quelle condotte tenute dal dipendente al di fuori dei luoghi di lavoro (ad esempio, nel caso in cui il lavoratore dovesse essere condannato per il reato di violenza privata nei confronti di un convivente) che potrebbero essere considerate del tutto irrilevanti sul piano lavorativo e, dunque, per quella via, insussistenti anche a livello materiale (una insussistenza, diciamo, dal punto di vista del rilievo disciplinare). Merita infine un’ultima riflessione il tema dell’onere della prova del fatto contestato. A parere di chi scrive, la recente novella in tema di tutele crescenti non ha eliminato il principio base secondo cui – in sede giudiziale – spetta al datore di lavoro dimostrare l’esistenza dell’addebito mosso al dipendente licenziato ai sensi dell’art. 5, della legge 604/1966. Del resto, quand’anche il fatto contestato fosse davvero avvenuto ma non ve ne fosse la prova in giudizio, il magistrato seguirebbe il noto brocardo latino secondo cui quod non est in actis non est in mundo. Dal canto suo il lavoratore, al cospetto della prova del fatto, sarà tenuto a provare la sussistenza del relativo fatto estintivo ai sensi dell’art. 2697 del codice civile (ad esempio, se il datore di lavoro licenzia il dipendente per non aver effettuato una consegna a un cliente in un determinato giorno, il lavoratore dovrà provare che, in quello specifico giorno, il suo responsabile lo aveva adibito a un’altra attività che gli ha reso impossibile effettuare la consegna). In conclusione, il decreto legislativo 23/2015 ha provato a mettere ordine nel panorama giuslavoristico dei licenziamenti disciplinari, con l’obiettivo dichiarato di restringere ulteriormente – per i nuovi assunti a tutele crescenti – la discrezionalità dei giudici
in relazione alle tutele da riconoscere ai dipendenti illegittimamente licenziati. A tale scopo, il legislatore ha privato il CCNL e il codice disciplinare di quell’efficacia che gli era stata assegnata dalla legge 92/2012, retrocedendoli nuovamente a una mera fonte di orientamento nel giudizio di proporzionalità tra infrazione e sanzione disciplinare. Sulla base di tale valutazione di proporzionalità, tuttavia, a differenza del recente passato, il lavoratore non potrà ottenere un ordine di reintegrazione, bensì una tutela di carattere esclusivamente economico. Il nuovo impianto normativo ha senz’altro il merito di consegnare nelle mani del datore di lavoro uno strumento per quantificare
con maggiore certezza il costo economico di un provvedimento espulsivo, laddove non ritenuto dal magistrato legittimo. Allo stesso tempo, per evitare il rischio di un esercizio incontrollato e distorto del potere disciplinare, il decreto legislativo 23/2015 ha previsto che, in caso di licenziamento ritorsivo e/o discriminatorio, il lavoratore
possa ottenere la reintegrazione in servizio, oltre che l’indennità risarcitoria. In questi termini, anche utilizzando sapientemente lo strumento delle presunzioni, il prestatore di lavoro licenziato per una ragione all’evidenza
pretestuosa o capricciosa potrà addurre e dimostrare in giudizio che il reale motivo alla base del recesso datoriale non può essere identificato nel fatto contestato, bensì in ragioni ulteriori di carattere ritorsivo e/o discriminatorio. In tale ipotesi il datore di lavoro non potrà comunque evitare la condanna al ripristino del rapporto di lavoro.
Ciò detto, sarà interessante esaminare le prime pronunce della Suprema Corte in tema di licenziamenti disciplinari regolati dal decreto legislativo 23/2015, soprattutto nel momento in cui i giudici di legittimità, poco inclini a essere imbrigliati nelle maglie tessute dal legislatore, dovranno esprimersi su provvedimenti espulsivi manifestamente
sproporzionati rispetto alla entità della mancanza contestata, ovvero adottati per condotte che, palesemente, non possono incidere in alcun modo sul vincolo di fiducia tra datore e prestatore di lavoro. In proposito, può essere utile richiamare una recente sentenza della Suprema Corte che, seppur emessa a definizione di un giudizio relativo
a un licenziamento in regime di vecchie tutele (non tutele crescenti), sembrerebbe lanciare un monito ai datori di lavoro: “Deve peraltro chiarirsi che non può ritenersi relegato al campo del giudizio di proporzionalità qualunque
fatto (accertato) teoricamente censurabile ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile” (Cassazione civile, sez. lav., n. 18418 del 20 settembre 2016).
* Avvocato, socio dello Studio Ichino, Brugnatelli e Associati;
** Avvocato, componente dello Studio Ichino, Brugnatelli e Associati.

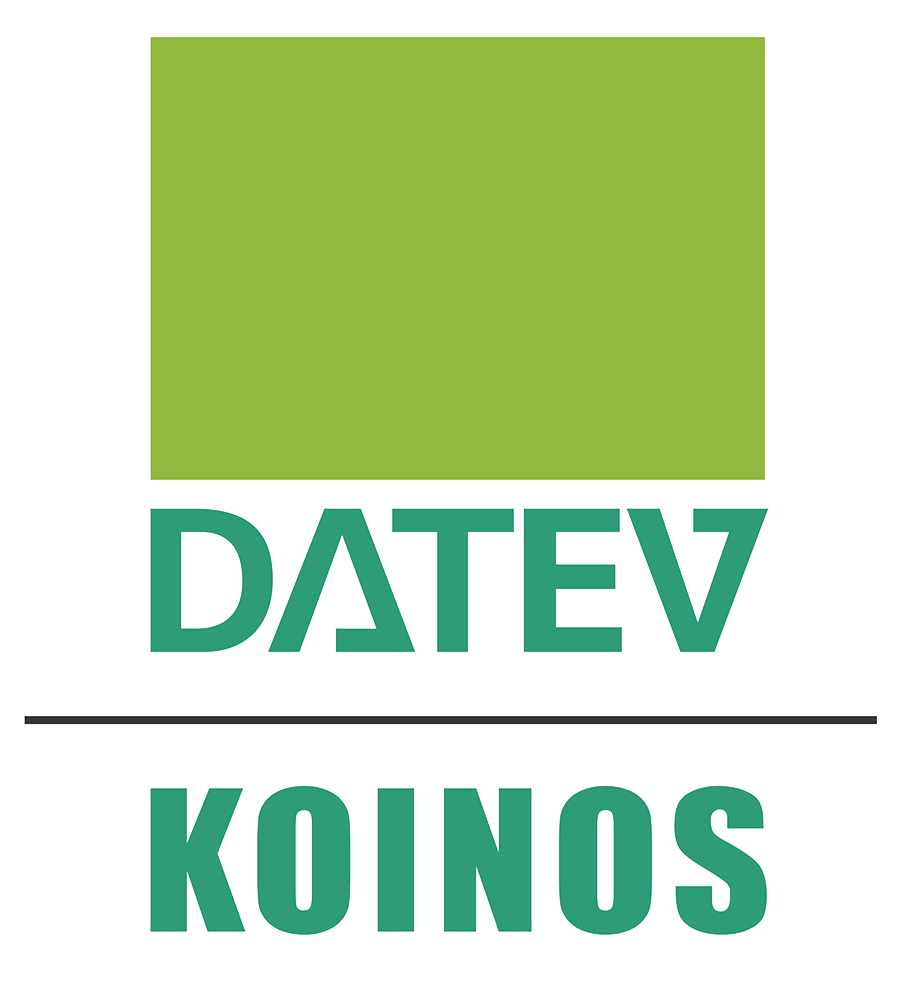






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!